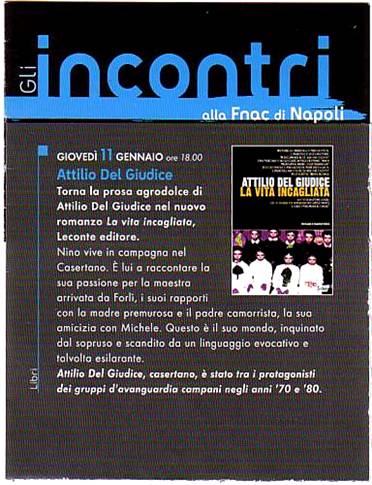ATTILIO DEL GIUDICE
postfazione di Francesco Piccolo
Ed. LECONTE (aprile 2006) collana: I TROVATORI
I minuti che passano ora possono anche essere puri,
ma certo tali non furono tutti i secoli che ti prepararono
(Italo
Svevo, La Coscienza di Zeno).
I' respiro ma nun abbasta ancora nun abbasta nun abbasta
si nu rispiri tu vicino a
me
(Almamegretta,
Respiro).
Nino vive in campagna nel
Casertano, fa la quinta elementare. E' lui a raccontare la sua passione per la
maestra scesa da Forlì, i suoi rapporti con la madre premurosa e il padre
camorrista, la sua amicizia con Michele. Ecco il suo mondo, inquinato dal
sopruso e scandito da un linguaggio che mostra rispetto per la realtà orale di
questa porzione del sud. Un linguaggio che in qualche modo nazionalizza il
dialetto per approdare a un italiano deformato, spesso esilarante,di certo
evocativo quanto il peso di uno sguardo o il colore della terra macchiata di
sangue. Un autentico idioma di agilità gaddiana,
capace di fare delle storie di Nino una struggente metafora della solitudine
meridionale.
(L’ASSO NELLA MANICA)
Caro lettore,
forse, prima di acquistare e leggere questo libro, prima di fruire di una
qualche qualità espressiva, vuoi sapere quali siano state le intenzioni
dell'autore. Si sa che le intenzioni sono una piccola cosa fallibile e un
romanzo una volta scritto, aspira ad andare oltre e a camminare per conto suo,
ma, per quel po' che possono valere, te le dico in due parole. Ho inteso
parlare di un ragazzino di dieci anni e, attraverso il suo linguaggio, della
sua condotta psicologica: le sue morbosità di adolescente, la levità, gli
affanni; attraverso ì suoi affetti e i suoi rapporti umani, ho inteso parlare
di una comunità contadina, arcaica in alcuni riti e valori, ma brutalmente
ammodernata dalla cultura del sopruso e della violenza. Un concentrato di
drammatiche contraddizioni, un disagio nella vita civìle
che investe intere regioni del Mezzogiorno. Questo non era il mondo della mia
infanzia lontana (altre, semmai, furono le lacerazioni), ma mi sono convinto
che gli scrittori del Sud e anche i più umili facitori
di storie non possono eluderlo, se vogliono rinforzare le esili e scabre
ragioni della scrittura narrativa col peso della realtà e cercare l’incontro
con i lettori su un terreno più sicuro. (attilio del
giudice)
LA POSTFAZIONE DI FRANCESCO PICCOLO
La vita
incagliata è per Attilio Del Giudice una sorta di resa dei conti. Ma alla fine,
ogni romanzo è una resa dei conti. Se uno dicesse una frase stupida come: ho
necessità di capire alcuni nodi della mia vita, si potrebbe rispondergli che
questo è il suo progra mma letterario fino alla fine dei suoi giorni. Però uno
scrittore si mette dentro una storia, sceglie un punto di vista molto basso – in
questo caso, un ragazzino un po’ ignorante – e a quel punto non gli rimane che
stendere un mondo intero davanti, come quelle enormi lenzuola bianche che le
madri facevano volare in alto prima che cadessero dolcemente sul letto, e
nell’attimo in cui volavano per la stanza coprivano ogni cosa, erano tutto il
mondo che si poteva vedere, e se tutto il mondo per un secondo è morbido e
bianco, ci si può mettere dentro (scrivere) quel che si vuole. E allora questo
ragazzino, la sua lingua sgrammaticata che accompagna un pensiero semplice e
intanto potente per il fatto di voler essere indagatore, non può essere altro
che commovente. Perché dentro il candido sguardo (e di conseguenza sopra le
candide lenzuola) ci sono cose molto serie: il dolore, la violenza, e la
tenerezza di alcune intuizioni liriche di questo io narrante malmesso che
attraverso la fatica delle parole da trovare, buone o cattive che siano, riesce
a far passare tutto quel che deve passare. Solo che quel che passa è la vita
che si è incagliata. Del resto, cosa c’è di commovente in quelle lenzuola che
volano per la stanza prima di cadere morbide sul letto? Non c’è nulla, prese
così da sole: sì, il gesto e la morbidezza; sì, l’odore di pulito; ma quel che
commuove è altro: è il peso della storia di quella stanza, è la bellezza di una
madre che sfiorisce, è la grandezza dell’amore che chi guarda ha per tutto
questo. Solo che quell’amore così grande è inesprimibile, sia per timidezza sia
per ostentazione, perché nemmeno un abbraccio e una dichiarazione possono
davvero raccontare quel che costituisce il sentimento.
mma letterario fino alla fine dei suoi giorni. Però uno
scrittore si mette dentro una storia, sceglie un punto di vista molto basso – in
questo caso, un ragazzino un po’ ignorante – e a quel punto non gli rimane che
stendere un mondo intero davanti, come quelle enormi lenzuola bianche che le
madri facevano volare in alto prima che cadessero dolcemente sul letto, e
nell’attimo in cui volavano per la stanza coprivano ogni cosa, erano tutto il
mondo che si poteva vedere, e se tutto il mondo per un secondo è morbido e
bianco, ci si può mettere dentro (scrivere) quel che si vuole. E allora questo
ragazzino, la sua lingua sgrammaticata che accompagna un pensiero semplice e
intanto potente per il fatto di voler essere indagatore, non può essere altro
che commovente. Perché dentro il candido sguardo (e di conseguenza sopra le
candide lenzuola) ci sono cose molto serie: il dolore, la violenza, e la
tenerezza di alcune intuizioni liriche di questo io narrante malmesso che
attraverso la fatica delle parole da trovare, buone o cattive che siano, riesce
a far passare tutto quel che deve passare. Solo che quel che passa è la vita
che si è incagliata. Del resto, cosa c’è di commovente in quelle lenzuola che
volano per la stanza prima di cadere morbide sul letto? Non c’è nulla, prese
così da sole: sì, il gesto e la morbidezza; sì, l’odore di pulito; ma quel che
commuove è altro: è il peso della storia di quella stanza, è la bellezza di una
madre che sfiorisce, è la grandezza dell’amore che chi guarda ha per tutto
questo. Solo che quell’amore così grande è inesprimibile, sia per timidezza sia
per ostentazione, perché nemmeno un abbraccio e una dichiarazione possono
davvero raccontare quel che costituisce il sentimento.
In questo un romanzo è coraggioso. Perché prova a mettere in moto un meccanismo
che nel suo dispiegarsi complesso e tangente alla vita, prova a dare la misura
dei sentimenti – e in questo caso, dell’impossibilità di esprimere una
personalità, sia pure fragile e inadeguata, dentro e fuori la famiglia. Gli
accadimenti dolorosi sono troppo tragici per essere presi di petto, per questo
il ragazzino prova a ragionare di sbieco, a prenderli alle spalle, a girarci
intorno: è sia la misura dei suoi mezzi, sia la protezione che i suoi mezzi gli
hanno dato. Ma non c’è niente da fare: se la vita si incaglia, si incaglia.
Il lavoro sulla sintassi meridionale, nei libri di Attilio Del Giudice, è
meticoloso, pernicioso, anche testardamente manierato. È’ il suo modo di
sfondare, sfrondando, il senso del dolore e questa condanna ben accolta che è
la meridionalità. Il maresciallo Capece
e il commissario De Grada sono stati i primi attori
di questa finta commedia che sfociava nel giallo anomalo ma soprattutto
penetrava nell’esistenza della vita umana da compiersi tutta sotto il sole
della controra, a combattere con il cibo della trattoria, con la bellezza
sudata delle donne. E qui, nella Vita incagliata, lo scenario è lo stesso, una
sorta di silenzioso protagonista che senza quasi muoversi invade tutto, i corpi
dei personaggi, i pensieri morbosi, la lingua fino alla sintassi del flusso di
coscienza che si frantuma in un ragionamento faticoso per capire qualcosa del mondo.
Del Giudice quindi sceglie di non voltare le spalle al peso della provincia
antica, ma la prende di petto e si abbandona come tra le braccia di una signora
grassa che non è solo felliniana, ma anche campana.
Tutto questo, per me, ha a che fare con la mia vita di provincia e con il
rapporto che con Attilio ho avuto nella mia vita di provincia, quando solitario
e pieno di generico desiderio di espressione, quando insomma la mia sintassi e
la mia età assomigliavano per inadeguatezza al protagonista-narratore della
Vita incagliata, come si assomigliano tutti gli inadeguati ragazzini
provinciali del mondo, avevo come punto di riferimento una porta che
assomigliava a tutte le altre di un piccolo parco con villette a schiera.
Fermavo il mio motorino lì fuori e avevo sempre difficoltà a essere sicuro che
quella fosse la porta giusta, o forse quell’altra, fino a quando Attilio
appariva su un’altra soglia ancora. Andavamo su un divano e così ho passato
alcuni pomeriggi della mia vita, ad ascoltarlo molto e a parlare poco (e
balbettando) di letteratura, arte, cinema ma anche di donne e di ricordi. E poi
uscivo che era buio, e sulla porta Attilio parlava ancora, quasi impendendomi
di andare via, e poi richiudeva e io saltavo sul motorino e ogni volta mi
sentivo come se mi avessero cambiato la bombola del gas e potessi ricominciare
ad andare avanti per qualche altro mese, nel mondo scoraggiante dove stavo,
pensando che quella mia generica volontà di esprimermi non era astratta se
c’era qualcuno che raccontava di averla avuta e che la rendeva concreta
attraverso le cose che faceva. Uscivo da casa di Attilio e mi dicevo
semplicemente: c’è qualcuno che è come te, quindi ce la puoi fare. E questo
nella mia vita è stato molto importante.
Il problema era, evidentemente, che la vita non si incagliasse definitivamente.
O, se si era già incagliata, come del resto mi sembrava, ci fosse la
possibilità, un giorno, che si sciogliesse. Per questo mi sento vicino al
protagonista di questo romanzo, che pure ha delle ragioni più grandi delle mie
per sperare in qualche scioglimento. Ma è così: il lettore partecipa di un
romanzo per un’adesione vaga, non precisa né proporzionata. E quando l’orrore è
morbido e vicinissimo, quando tocca la famiglia, gli amici, la maestra e la
strada dove si vive, quando è addolcito e nascosto dalla quotidianità, diventa
immediatamente il mio orrore personale, e io non sono più io ma il protagonista
de La vita incagliata. Una cosa semplice.
L'INCIPIT
"Da dieci giorni abbiamo una
nuova maestra. La nuova maestra parla tischitoschi,
perché viene da una città dell'Alta Italia che si chiama Forlì e tiene la
faccia uguale uguale all'Arcangelo Gabriele che sta pittato nella chiesa di Santa Rita, subito entrando a
destra."
I RISCONTRI
CRITICI
«La vita incagliata» di Del Giudice
spietato, poetico ritratto di un mondo
Sguardi di bambino sul nulla degli adulti
CORRIERE DEL
MEZZOGIORNO DOMENICA
5 NOVEMBRE 2006
di FRANCESCO
DURANTE
Con La vita incagliata (Leconte, 152
pagine, 15 euro; affettuosa postfazione
firmata da Francesco Piccolo), il casertano
Attilio Del Giudice ha composto secondo
me il migliore dei quattro romanzi
che ha sinora pubblicato. Ho usato deliberatamente
il verbo «comporre» — e
non «scrivere» — giacché mi pare di cogliere,
in questa breve e intensa, vivace e
mossa narrazione, un assai lodevole sforzo
di concentrazione, mi verrebbe quasi
da dire di rarefazione, che a partire dal
sorvegliatissimo uso
della lingua si estende
poi alla tessitura
propriamente narrativa,
che da quell’uso
sembra quasi farsi
strada come per un
esito naturale.
A differenza dei tre
romanzi precedenti
Morte di un carabiniere
(1998), Città amara
(2000) e Bloody muzzarè
(2004), che
tutti insieme formano una trilogia cui
soltanto per semplificare potremmo allegare
l’etichetta «noir» (ma forse al primo
Del Giudice meglio si attaglia quella
più tradizionale di «poliziesco»), qui lo
scrittore procede a una riduzione dei
suoi materiali, a una scomposizione del
meccanismo, a una sua minimalizzazione
che si fa rapsodica e si costituisce in
brevi cellule narrative (quasi) indipendenti.
La scelta risulta particolarmente
opportuna dal momento che quella che
Del Giudice racconta non è una «storia»
compiuta, bensì l’obliquo apprendistato
alla vita di un ragazzino, Nino, che vive
nella campagna casertana e frequenta
la quinta elementare. Il libro, anzi, si
finge direttamente scritto da Nino, con
una scelta che gli sperimentatori francesi
del vecchio Oulipo avrebbero potuto
definire una contrainte, una specie di costrizione
o di regola che obbliga chi la assume
a conformarsi a tutta una serie di
accorgimenti i quali, al di là della pura
esigenza mimetica (di credibilità del personaggio
narrante), si costituisce in primo
luogo come il punto di partenza per
un tour de force del linguaggio che ha il
non piccolo merito di porre un argine a
certe ridondanze, a certi eccessi, a certi
facili effetti di cui molta letteratura iperrealistica
di ascendenza post-cannibalesco-
tarantiniana risciacquata nelle non
cristalline acque del golfo di Napoli è infarcita
ormai al limite della più stucchevole
sazietà.
Invece, per far parlare Nino, Del Giudice
deve compiere un misericordioso percorso
a ritroso — nella memoria, nella
sua sensibilità più profonda—e costruire
qualcosa di fresco, di non usurato. Il
suo patois, un felice impasto di italiano
regionale e dialetto, mi si è imposto come
una delle lingue più «naturali» che
mi sia capitato di leggere in questi ultimi
anni, e sono felice di additarlo a esempio
di probità e misura, oltre che per la
felicità di certe soluzioni (ne dico una
soltanto: la caratteristica declinazione
del passato remoto, per cui, ad esempio,
«Michele penzai»).
Vengo ora a dire che cosa ci racconta
Nino con questa sua bellissima voce
(questa è sempre la parte più ingrata
di una recensione). Nino dunque racconta
quello che vede intorno a sé: a casa,
dove una madre tenera e affettuosa
è confinata alla solitudine delle sue speranze
frustrate da un marito che è uomo di
rispetto, becero e arrogante e violento
— uno che al figlio non manca
mai di rivolgersi chiamandolo «strunzo";
a scuola, dove c’è una maestra che
sembra una fatina buona piovuta da un
favoloso altrove che si chiama Forlì;
per le strade, a giocare, a pedalare, a
correre, a scoprire tutto l’infinito mondo
che c’è da scoprire a quell’età, insieme ai
suoi coetanei presi da tutte le turbe
ormonali del caso.
Lo sguardo di Nino è insieme innocente
e impassibile. Sotto i suoi occhi cade
lo squallore quotidiano di una provincia
abbandonata e regolata da norme di
convivenza tribali, e il racconto che ne
viene è nient’altro che il veridico resoconto
di ciò che accade in «un paese che
se fai una cosa buona, nessuno se ne accorge;
ma appena appena sgarri lo sanno
tutti quanti».
Grava su questi luoghi, su questa specie
di Twin Peaks di Terra di Lavoro, il
sentore come di una maledizione popolata
di fantasmi, come quello di Nennella,
la sorellina che «murette che io ero
piccolo»: «Non si trovava più e, poi, dopo
un sacco di ricerche la pescarono nel
canalone, che dice che teneva la pancia
gonfiata come una zampogna». Del Giudice
è molto bravo nel dosaggio narrativo,
nel far sì che la tensione sottile che
dagli uomini si è trasferita allo stesso paesaggio
non venga mai meno, neanche
quando ciò che racconta, come succede
spesso, muove al sorriso. Così è anche
nel delicatissimo capitolo finale, il più incantato
e amaro di questa commovente
storia di una infanzia miracolosamente
in equilibrio sul nulla lasciato dai padri.
|
31/10/2006 IL
MATTINO FRANCESCO
DE CORE Infanzia negata e vita incagliata per il figlio della camorra La scelta di non voler più crescere come Oskar del «Tamburo» di Grass
|
|
|
STILOS (26 Settembre 2006) - IL PRESEPE DI PLASTICA (Novembre 2006)
di NICOLO' LA
ROCCA
Nino vive in provincia di Caserta,
frequenta la quinta elementare, ha una maestra che parla tischitoschi,
un padre camorrista, una madre ansiosa, una casa con un grande terrazzo nel
quale non c’è niente, soltanto un filo per il bucato; proprio come il
quotidiano di questo bambino, un niente attraversato da un sottile ma duro filo
di cose e di persone, di pomeriggi trascorsi osservando i giocatori di biliardo
di un bar e fumando sigarette di nascosto. È una vita incagliata, quella del
protagonista del nuovo romanzo di Attilio Del giudice, un’esistenza impantanata
nella provincia criminale, perché il crimine, in questo dagherrotipo campano
evocato dalla lingua sincera e dialettale del bambino, non è altro che una
delle tante variabili della sua vita; sta dalla parte del padre, figura di
camorrista con le mani in pasta ovunque, sta nelle strade periferiche del
paese, affollate di prostitute e “ripulite” quando deve arrivare in città un
pezzo grosso della politica, sta nelle facce cicciute dell’onorevole che va a
trovare il padre per degli accordi misteriosi. Questo mondo feroce fatto di
abusi, brutalità, sottomissioni e angherie viene normalizzato dallo sguardo
ingenuo del bambino: così, grazie all’efficace artificio della regressione
utilizzato da Del Giudice, passano in rassegna davanti agli occhi del lettore
tutte le disumanità immaginabili nel microcosmo della provincia campana, e
questo narratore singolare ci fa capire che la normalizzazione non è soltanto
nella sua voce, nel suo punto di vista, ma ovunque. Sintomatica, a tal
proposito, è l’entrata in scena di un politico: nel romanzo è una figura
sfocata e laterale. L’onorevole farà capolino per scomparire subito. Sarà il
padre di Nino, camorrista un po’ guascone a pagare, a restare in primo piano. È
un’opera insolita e preziosa, La vita incagliata, è come un libro mastro
del mondo provinciale campano, non ingabbia il fluire della realtà nelle
convenzioni incipit-sviluppo-finale. Gli ambienti, le
microstorie, i personaggi che ogni capitolo ci offre sono di pura invenzione,
ma restii a farsi domare dai ricettari più recenti della fiction e della faction. Il protagonista del romanzo, pagina dopo pagina,
accumulando le sue giornate con un taglio diaristico,
ci offre il suo mondo lasciando che sedimenti sulle pagine del libro. La vita
incagliata di Nino si deposita davanti al lettore e la sua voce disarmante,
curiosa ma docile, buffa ma triste, ne rivela tutto il carico di dolore.
IL
ROMA (CULTURA - 13 Gennaio
2007)
LA VITA
INCAGLIATA E’ IL NUOVO ROMANZO DI ATTILIO DEL GIUDICE
LE
VICENDE AMARE DEL PICCOLO NINO
di ROSARIA MORRA
Nino
conosciuto in provincia di Caserta come “”o figlio
‘e
Sigaretta”, è il piccolo protagonista
di un
disordine sociale. La sua famiglia
è infatti
composta da Alfò, l'irascibile padre
camorrista,
e da Angelina, la buona mamma
che
sopporta gli atteggiamenti del marito e
la
condizione di moglie di un criminale. Ma
c’è anche Nennella, la sorella maggiore di
Nino,
tragicamente affogata nel fiume, il cui
ricordo è
sempre vivo nel cuore della madre.
Questi i
protagonisti di “La vita incagliata”,
quarta
opera narrativa di Attilio Del Giudice
(nella
foto), scrittore casertano, pubblicata
dalla
capitolina Laconte. Il libro, presentato
al Forum Fnac, nel cuore del Vomero,
ha i
«colori agrodolci del Meridione», come
spiega
Carmine Aymone, giornalista intervenuto
per
l’occasione. «Il registro adottato
- dichiara
Del Giudice - non è quello lirico
di Di Giacomo, né quello espressivo di
Viviani,
non è neanche quello piccolo borghese
di
Scarpetta e neppure quello canagliesco
tipico dei
vicoli: è il dialetto povero
della
provincia». Il carattere drammaturgico
rappresentato
dai 52 capitoli-sequenza,
scritti
nel “diario” di Nino (voce narrante del
romanzo),
istantanee di una quotidiana sopravvivenza,
sorprendentemente
vicine al
neorealismo
Pasoliniano, si fonde con il carattere
squisitamente
letterario, reso attraverso
l’accuratezza
della scrittura, poiché rimane
intatta
l'elaborazione letteraria dei
termini
dialettali campani, qui trascritti con
le giuste
regole segniche dell’elisione. Le forme
espressive
gergali (l’uso dell'erroneo ausiliare
“avere” ad
esempio) risultano quindi
veraci e
credibili. Nel complesso un italiano
artisticamente
vicino a quello di Gadda
e
Camilleri. «Ho arbitrariamente deciso
di non
sottrarmi al codice deontologico di un
autore -
afferma Del Giudice - ossia inverare
i propri
personaggi»; ecco quindi spiegato
come
questo, seppur breve, spaccato di vita
così
autenticamente ritragga la realtà. A
colpire la
violenza che permea la vita di Nino:
quell’abuso
che, a pagina 67, sconvolge
il
precario quanto delicato equilibrio in cui
(sopra)
vive. “Incagliata”, fisicamente e moralmente,
l’anima di
Nino ben si chiarisce
con la
metafora del “fiore di loto” tanto bello
eppure
circondato da lerciume. Tuttavia
il tanfo
non nausea l’innocente protagonista
a cui però
è bene non associare né una facile
retorica
né una descrizione ordinaria
del
disagio provato. La sua parlata spontanea,
che tanto
ricorda gli studenti descritti
da
Marcello d’Orta, pone l’accento su episodi
ironici ma
mai grotteschi. Mirabile la bravura
della
penna di Del Giudice: «è stimolante
per
uno scrittore scandagliare i propri
ricordi
per riprodurre qualcosa che lui stesso
ha
provato»; credibilissimo nella regressione
alla mente
di un bambino di dieci anni,
presa solo
dal presente. Dopo alcune ottime
prove
letterarie di genere poliziesco e
noir,
arriva questo piccolo gioiello di 149 pagine
che ben si
presta ad una lettura insolita
e
pregevole: la sua è pura invenzione che,
però, si
fa denuncia dell'attuale situazione
sociale. E
ai tanti Nino che oggi esistono l’appello
a chiedere
aiuto a chi non usa la violenza
ma il
dialogo.
|
Luigi De Luca - Redazione Aphorism.it (18-05-2006) Attilio Del Giudice torna in
libreria. Questa è una bella notizia che apre la nostra recensione. Due anni
dopo Bloody Muzzare’, che
ha chiuso la trilogia dei tutori dell’ordine De Grada
e Capece, arriva il nuovo lavoro ancora edito da Leconte. Una bella edizione, curata, con 149 pagine
ricche di vicende raccontate in capitoli brevi e densi. La struttura
narrativa pare smembrarsi dall’insieme, vuole dilaniarsi, per raccontarci
quanto più possibile la vita del protagonista, in tutti i suoi aspetti. Ed è
un piacere trovare Del Giudice ancora impegnato a giocare con l’italiano,
questa volta in maniera ancora più profonda: lascia che a “scrivere” la
vicenda sia il protagonista, Nino, un bambino di quinta elementare che si
racconta come se componesse il suo diario segreto. Gli occhi di questo
bambino, e il suo cuore, ci porteranno nella provincia campana, un territorio
che spesso sanguina e che il nostro Attilio conosce bene. Nino intinge la
penna in un italiano incerto, ricco di elementi presi in prestito dal
dialetto, co-protagonista assoluto delle vicende narrate. Così, tra violenza
ordinaria, squallore, prepotenza e codici d’onore della malavita organizzata,
un bambino si muove a metà strada tra i suoi coetanei e il mondo degli
adulti. Tra l’innocenza genuina e un po’ smaliziata di chi è costretto a
crescere in fretta, e le perversioni dei grandi, sempre alla ricerca
egoistica di soldi, piacere e potere. Nino sembra non capire la sfida che
l’attende: dovrà scegliere, un domani, se ereditare l’esperienza e la fama
del padre padrone o prendere la sua strada fatta di sogni e dolcezza. Quella
tracciata dalle due dolci figure femminili di cui è perdutamente innamorato:
la mamma e la maestra. Noi tifiamo per Nino, perché è buono, perché
rappresenta una speranza per tutti, perché solo nell’ultimo capitolo Del
Giudice ci fa capire cosa significa “la vita incagliata”, lasciandoci a bocca
aperta. E allora sì, non ci resta che sperare… |
Il Paradiso Degli Orchi (Rivista di Letteratura Contemporanea)
Recensione di Marco Lanzol
La vita incagliata
Leconte,
Pag.149 Euro 15,00
Fotografia (Tano
D’Amico?). Bambini di Palermo che giocano al “morto ammazzato” - stesi sull’asfalto
del cortile, col gesso si fanno disegnare intorno la sagoma del proprio corpo,
come si vede nei rilievi eseguiti dalla polizia per stabilire la posizione dei
cadaveri.
Notizia. Non gran tempo addietro, si seppe di un tredicenne di Scampìa (non un chierichetto: stava facendo una rapina)
ucciso da un agente dell’ordine. Poco dopo, in rassegna stampa, un articolo
(prima pagina, una colonna di spalla) su un quotidiano padano s’intitolava:
”Adesso non si può più neanche uccidere un baby-delinquente!” Perché esistono i
“bambini” - teneri, dolci, minacciati: un incrocio tra profiteroles e panda, insomma - e i
“baby delinquenti”. Che sono un’altra cosa. Una cosa che si può anche
ammazzare.
Benvenuti dunque i libri come questo di cui parlerò. Perché poco può fare un
libro, ma almeno cerca di restituire umanità a chi se la vede tolta dal mondo
(e dalle signore Babebibobù della stampa ”libera”).
Perché propone, com’è debito pagare dalla letteratura, una vita in una studiata
lingua che le si attagli (quando ci riesce), dunque rendendola forma (cioè
limite, confine, contorno). Perché, ad onta del fatto che di certe storie
sembra tutti sappiano tutto, bisogna raccontarle ancora e ancora, sicché ogni
particolare si delinei in pieno, dato che può essere usato da qualcuno per
mentire, cioè per deformare il complesso (direbbero i chimici) di vita e
lingua, ovvero di senso e significato.
Per quest’ultima, trattando di Sud camorrista, il mazzo di carte che l’Autore
rimescola è completo: c’è la ferocia ininterrotta dei criminali, che domina
ogni aspetto della propria vita e dei rapporti con gli altri, fossero anche i
famigliari (la moglie sgrommata di sangue a ogni occasione: il figlio
“imparato” a sparare, unico momento, assieme all’uso del rasoio per la barba e
“per qualche altra operazioncella” (p. 102),
d’intimità); l’ipocrita collusione dei manutengoli politicanti, ricattatori
protervi e insaziabili, sazi solo d’impunità; la donna, come l’uomo, chiusi in
ruoli intrasgressibili, ben più incamicianti del burqa - ogni maschio ladro e
molestatore, ogni donna moglie o zoccola; la viltà e più ancora l’annullarsi -
cementati da secoli di sciagurata oppressione - delle povere pecore che devono
vivere in mezzo ai lupi, che belano dinanzi alle loro zampe, incapaci persino
di lamentarsi quando sono dal barbiere; lo sfruttamento del lavoro - con la
sopravvivenza dei caporali a stravincere sugli uffici di collocazione - i cui
frutti vengono taglieggiati se non depredati fino all’ultimo soldo; uno Stato
colabrodo, che offre solo pomposi e inutili discorsi nelle scuole da parte di
maestri e “psicòli” (psicologi), burocratici
scaricabarile tra gli uffici ripittati d’un
europeismo ridicolo, squallidi ospedali dove il sudiciume dei luoghi suggerisce
l’incancrenirsi della malasanità - uno Stato per cui l’unica tiepida efficienza
é nel reprimere poliziottesco, ma incapace di far
volare altro che stracci (prostitute africane, pastori slavi).
Però, fra coteste carte nere, ecco la matta dorata:
Nino, che frequenta l’ultima classe elementare, e che è, lui figlio d’un lupo
camorrista, agnello sognatore - pure se contaminato (l’ambiente non determina
ma fa capitare): fa commissioni per il padre, e temendolo lo ammira (p. 101). Essì: Nino è buono, tant’è che spesso e volentieri il padre
lo qualifica di “strunzo” - e anche Michele, coetaneo
e amico, ogni tanto ha dei dubbi su di lui, sicché gli dà del “filosofo”. (p.
121) Ma l’incertezza non coinvolge la sfera sessuale: i due porceddùzzi
si ammazzano di pippe sulle riviste porno, e sui
rotocalchi dove quelle “della televisione” stanno “tutte con le zizze da fuori
che fanno arrapa’” (p. 102); s’inguattano per vedere
le ragazzette nude e le monte delle puttane nere come le bufale da latte; e
svicolano dalle avances di un ricco pedofilo che vorrebbe conquistarli per
pochi soldi - i due furbacchioni fregandogli perdipiù
un costoso zìppo. Ma in tale canaglieria, Nino
distingue un’emotività più profonda, quella per la maestra bona
e dalla parlata “tìschitòschi”, ovvero settentrionale
- che, pur manifestandogli un affetto manierato e zuccheroso, predilige un
allievo più grande.
Bene: in questo Cuore di tutti Franti sorge questo disincantato e
spaurito Muratorino a fare da controcanto, col grave
compito di passare integro fra i rulli d’acciaio dell’ambiente-laminatoio in
cui si ritrova a vivere. Ci riesce - riesce a disincagliarsi, a uscire dalla
morta gora delle vite a rischio, in cui si viene uccisi ragazzini col plauso
delle biondone nordiste? L’Autore non lo dice: dà per
sicura la fine per ammazzamento del padre, ma di Nino lascia il dubbio che
sopravviva all’agguato, a voler sottolineare come in Italia (non nel Ruanda, o
nella Columbia de La vergine dei sicari) ci siano posti dov’è
chiesto di morire per vivere.
Parlando ora della forma che realizza la materia lucidamente oscura, l’Autore
assume il suo eroe come antagonista e narratore, e l’offre al Lettore in una
lingua ambigua, né italiana né napoletana, ma napoletanesca
(il dialetto si cala nella lingua non per contaminarla, ma come vaccino che ne
suscita anticorpi e la fortifica - anche se c’è sempre il rischio
dell’adulterazione glocalistica alla Marcello
D’Orta), che rende visibile nella sua doppiezza il conflitto tra il mondo
ferino ma reale dei rei, e l’iperuranio istituzionale
delle “parole giuste”, quelle (ben settantamila!) che stanno nel vocabolario
d’italiano che mamma Lupa compra al suo lupacchiotto, perché ci tiene che suo
figlio “s’impara” - ansiosa d’una normalità che lui si sforza di raggiungere,
tanto da discutere (analitico) con Michele dei motivi che fanno una parola
“giusta” o “sbagliata”. Quello, pragmatico, gli ricorda che sono decisioni da
“scienziati” - ne abbiamo fatto conoscenza, nel testo, sotto le spoglie dei “pisicoli” (psicologi). Sottintendendo: la partita l’abbiamo
persa, diversi ci giudicheranno, sui loro metri un poco artefatti risulteremo
sempre fuori misura, sempre vinti. Sempre figurine o di presepe o di teatro
crudele, (in)espresse dalle “meglio parole”, quelle “che non si dicono”. (p.
87) Parole di realtà, segni su segni come corpi su corpi. Come il segno di
gesso - a contorno del corpo - su una strada. Marco Lanzòl
IDEALIA (LETTERE CIRCOLANTI)
di SERGIO
SOZI
Modeste glosse a La vita
incagliata di Attilio del Giudice (Leconte, Roma 2006)
Di
questi tempi, leggere la nuova narrativa italiana è come fare una scelta di
campo, soprattutto dal punto di vista linguistico: o con l'abusato, sciatto,
impersonale italiano medio di molti, o nelle intricate vie lessicali dei
realisti – o di chi al realismo s'ispira in un modo o nell'altro. Pochi autori
stanno fuori da questi due schieramenti o dimostrano acume interpretativo, pur
restando nei ''correntoni'' attuali.
Dunque, sarà perché il sottoscritto
(almeno come narratore) non riesce a soggiacere a questa banale miseria
generalizzata; sarà per via di una simpatia istintiva che queste pagine
inducono in me; o forse sarà a causa della mia convinzione secondo cui ogni
opera contemporanea debba esser vagliata alla luce della Storia Letteraria
italiana. Ne sia quel che ne sia il motivo di fondo, credo di non dire una
sciocchezza a cuor leggero se ora dichiarerò la riuscita operazione
drammaturgico-letteraria consistente nella quarta opera narrativa di Attilio
Del Giudice, scrittore casertano prima in forza alla casa editrice romana
minimum fax e ora pubblicato dalla, sempre capitolina, Leconte. E come mai
rappresenterebbe un'operazione drammaturgico-letteraria, questo La vita
incagliata, uscito pochi mesi fa? Diversi sono i motivi per vederlo cosí:
l'aspetto drammaturgico sono i capitoli-sequenza, scritti nel proprio diario
dalla voce narrante, il bambino campano Nino: dei quadretti di quotidiana
sopravvivenza che tanto ci rimandano visivamente al neorealismo di Pasolini.
L'aspetto strettamente letterario è l'accuratezza della scrittura, poiché resta
chiara l'elaborazione letteraria dei termini dialettali campani, trascritti con
le giuste regole segniche dell'elisione eccetera. Le forme espressive
dialettali (largo uso dell'erroneo ausiliare ''avere'', del pronome personale
''ci'' per ''gli'', ecc.) sono veraci e credibili. Nel complesso ne risulta un
italiano esteticamente vicino a quello di Gadda e Camilleri – mutatis mutandis
naturalmente.
Ma il vero lato interessante di questa tristissima e commovente storia risiede
nella violenza della quale è intrisa la vita di Nino, nove anni d'età (un
bambino che sarebbe l'alter ego di Giamburrasca - tanto egli resta scanzonato e
puro - se non gli fosse toccata la malaugurata sorte di aver un padre brutale e
delinquente in un'Italia del Sud tremendamente novimillenaria): la violenza e
le connesse perversioni qui divengono quasi una pagana accettazione della
bruttura moderna, quasi come se l'incontro con uno schifoso riccone pedofilo
(Al Mitreo, p. 67) fosse la rievocazione di un rito, appunto, concernente il
dio Mitra. Il fondamentale particolare che, però, priva di fascino mitico la
violenza serpeggiante in primo piano nel corpo di questi racconti, sta nella
deficiente intelligenza del mondo in cui Nino, anima candidissima, nuota senza
provarne disgusto: una provincia ottusamente autoreferenziale (direi
autistica), depressa e affamata di spersonalizzazione e denaro, una provincia
che non vede l'ora di dimenticare qualsiasi propria origine antica per buttarsi
anima e corpo nella pomposa straniazione filo-americana. Niente di diverso
rispetto alla provincia lombarda, umbra o sarda, dopotutto. Dunque niente di
nuovo rispetto all'Italia post-bellica: violenza, sradicamento e solitudine di
massa.
Dunque, in questo
senso, La vita incagliata non straborda, per fortuna sua, nel mero ritratto
della decadenza, processo spirituale e storico che purtroppo vediamo anche
senza andarci a leggere dei libri che lo descrivano; appunto, il neorealismo
che ne costituisce le fondamenta evita di cadere nella trappola
dell'esagerazione e dell'iperbole ma ricorre piuttosto (secondo me
salvificamente) alla letteraria tenerezza, alla poetica dolcezza con le quali
Nino acquisisce il suo vero volto spirituale: quello, all'apparenza neutro come
un foglio di carta bianco, che ci offre la soluzione per i mali italiani
profondi e piú labirintici: resistere dentro, solo dentro di noi – nel limbo
della nostra complessa, atavica semplicità – a questa brutale privazione del
vissuto collettivo che ci costringe a rinunciare alla cura dell'infanzia
(soprattutto a quella che abbiamo sempre viva nel cuore) in favore di una
stonata idea della vita adulta.
E un indiretto
manifesto della malsana crescita (degli altri, di molti altri italiani), questo
romanzo-centonovelle dipinge, a veder bene, per mezzo della buona crescita che
(alla faccia delle circostanze aberranti) il nostro Nino forse avrà. Anzi che
sicuramente avrà, sempre che riesca a sopravvivere al padre insanus senex da
cui è maltrattato e agli altri stolti. Molto plausibilmente noi tutti, gli
adulti. Adulti solo nell'egoismo e nell'inciviltà. Sergio Sozi
|
di LUISA CARRADA Delle parole e
delle immagini di Attilio Del Giudice ho già parlato qualche
tempo fa sul MdS. E il link al suo sito è tra gli
Amici nell'indice di destra di questo blog. |
|
|
Sepanet - Cultura & Spettacolo Libri |
|||||||
|